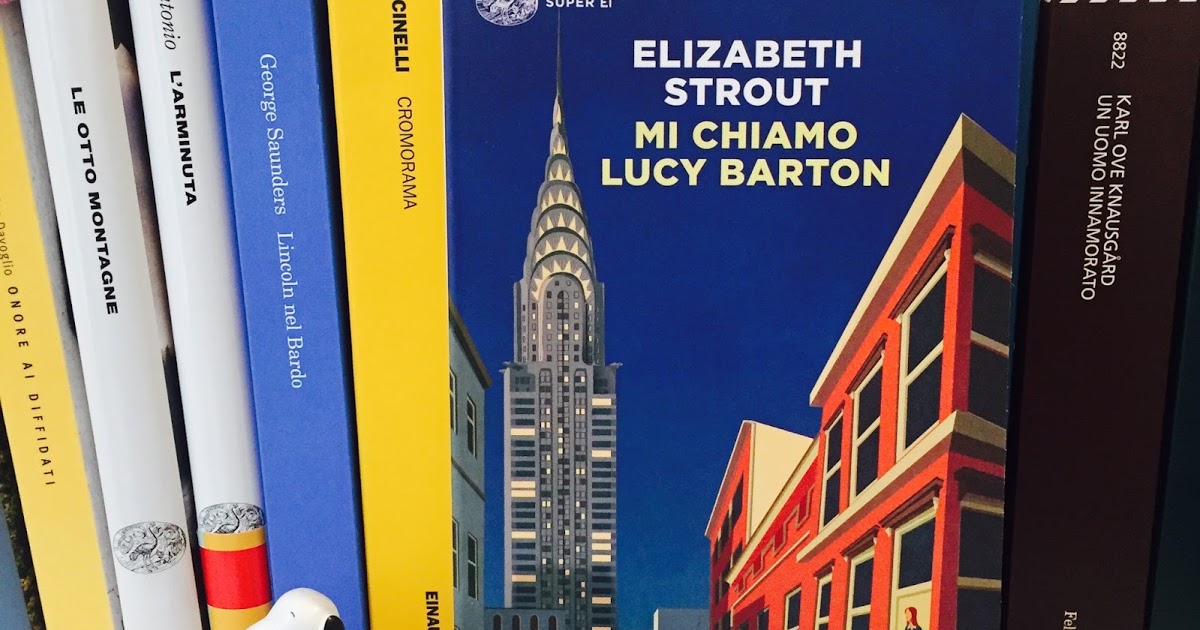[ngg src=”galleries” ids=”95″ display=”basic_slideshow”]La scrittrice americana Elizabeth Strout, famosa per la raccolta di racconti dedicata al personaggio di Olive Kitteridge, con la quale ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa nel 2009, ha fatto centro anche con il romanzo “Mi chiamo Lucy Barton”.
A detta di Claire Messud del The New York Times il libro ė “Un romanzo perfetto, nelle cui attente parole vibrano silenzi” e tra le cui righe si dipana “una rara varietà di emozioni, dal dolore piú profondo fino alla pura gioia».
La vicenda vede protagoniste due donne, madre e figlia, che, dopo tantissimi anni, si ritrovano in una stanza di ospedale. E si riscoprono, nonostante il rapporto conflittuale e le tante incomprensioni che le hanno allontanate per lungo tempo, capaci di raccontarsi e di raccontare.
Ricuciono, così, storia dopo storia, lo strappo causato da un’infanzia mal vissuta, dalla quale Lucy era fuggita, allontanandosi definitivamente dalla provincia e dalla madre.
Il romanzo si snoda su tre linee temporali che abbracciano presente, futuro e passato : la prima, vede Lucy e la madre in ospedale; la seconda, vede Lucy, ormai più vecchia, alle prese con la sua brillante carriera di scrittrice; la terza, forse la più sofferta, vede Lucy, sua sorella e suo fratello, nella loro vecchia casa, in un paesino isolato, poveri e soli.
Da quella solitudine la nostra protagonista fuggirà, lasciando il suo piccolo paesino per la grande New York, ma non dimenticherà mai il suo passato.
L’aspetto forse più interessante di quest’opera è che si rivelata uno strumento perfetto per narrare la sofferenza dei figli. Le ferite della piccola Lucy non sono poi così diverse da quelle delle sue due figlie. Ed è Lucy, da adulta, a capire ciò, domandandosi e rispondendosi:
«Io lo capisco il dispiacere che hanno avuto le mie figlie? Sono convinta di sì, ma è possibile che loro la pensino diversamente. Eppure conosco anche troppo bene il dolore che noi figli ci stringiamo al petto, so che dura per sempre. E ci provoca nostalgie così immani da levarci perfino il pianto. Ce lo teniamo stretto, invece, e lo difendiamo da ogni assalto del cuore: Questo è mio, è mio, è mio.»
Insomma, come ha giustamente osservato Hannah Beckerman del The Guardian la “Strout si conferma una narratrice grandiosa di sfumate vicende famigliari, capace di tessere arazzi carichi di saggezza, compassione, profondità. Se non l’avesse già vinto con Olive Kitteridge, il Pulitzer dovrebbe essere suo per questo nuovo romanzo”.